Quei tipi Plug & Play
Tenete bene a mente questo concetto che vado a esporvi: colui il quale cerca di mutuare la vecchia storia per cui chi ha vissuto i sessanta se ve li racconta significa non c’era e tenta di rifilarvi la stessa abbinandola agli anni settanta sappiate che è solo “un sòla”.

Giugno 1971. Roma, un caldo pazzesco.
“Un sòla”…lì per lì non capisco: una nota musicale di sol al femminile?, un uomo solo ma declinato male? Non “Un” ma “Una sola” nel senso di una sola volta, una sola cosa, la suola di una scarpa?…boh! Sinceramente non capisco.
Nel caldo romano odierno, di questi “un sòla” ce ne devono essere molti, o chi per loro in giro, visto che, davanti ai cancelli del Palaeur - dove mi trovo per un concerto pazzesco ed attesissimo da settimane e per il quale ho convinto la mia famiglia ad emigrare nella capitale - mi imbatto in una discussione sul gruppo che apre la serata e che, per l’animato relatore, è guidato da “un sola”. Giungo alla conclusione che, qualsiasi sia il significato nella migliore accezione del termine, sto’ sola ò è un ganzo o una mezzasega.
Il giovane in questione che conduce la discussione- canotta militare, ray ban da sole, capelli lunghi ondulati con la divisa su un lato, baffetti, jeans scampanati con bordino di merletto ricamato che denota una certa cura nel trattamento, clark marroni e, immancabile, tascapane – sta facendo capannello descrivendo il gruppo spalla come capitanati da “un sola”, un traditore che aveva mollato nel momento di maggiore successo il suo vecchio gruppo per formarne uno nuovo.
Il giovane, per un insieme di cose, dal tono della voce all’entourage che lo accompagna, anni dopo avrei pensato essere Nanni Moretti
Visto che io conosco a mala pena il gruppo in questione, se non per un album acquistato la settimana prima a Viareggio al negozio di Corrado Fontana, Fontana dischi (oggi Mondodisco), e che ho suonato a tutta manetta continuativamente per sette giorni, faccio fatica a entrare nel merito.

A me questi Humble Pie (così si chiama la band mentre il loro leader si chiama Steve Marriott, questo lo so!) mi sembrano molto ganzi, caro amico “un sola”, però mi esento dal dirglielo visto che non conosco nessuno intorno, che sono il più piccolo e che qui mi ci ha portato mio padre al quale ho imposto letteralmente di stare alla larga da questo luogo di rock & roll.
Infatti lui mi ha mollato all’inizio della Cristoforo Colombo e se ne è tornato in città eseguendo alla lettera i miei desideri (a 3 km dal palasport, che ho fatto a piedi, chi se la sentiva di chiedere uno strappo come tanti altri facevano…).
Insomma, il tipo, qui, fuori dal Paleur, va avanti un bel po’ in mezzo a un capannello che va aumentando di numero fino a che uno, più anziano, o almeno così sembrava - ma a dire il vero mi parevano tutti grandi quelli lì- uno con la barba lunga fino quasi alla pancia – che anni dopo ricollegherò essere Paolo Zaccagnini o il suo sosia – dopo averlo ascoltato un po’ con un sigaro fra i denti, non lo zittisce, tirandogli “una pizza” in viso, quasi facendolo cadere, mandandolo via piangendo e urlandogli dietro ”tu nun ce capisci un cazzo de stà robba!” e chiudendo la questione, per sempre, tra lo stupore generale.

Davanti ai cancelli del Palaeur, intanto, è un delirio.
La gente urla incazzata che non vuol pagare le 1500 lire del biglietto perché – affermano – il prezzo è troppo alto e che, se non entrano gratis, “sfondano”. Io, che ho un biglietto comprato all’Orbis, il box office degli anni settanta a Roma, svicolo dentro quatto quatto mentre fuori sento urlare slogan celebri dei cortei dell’epoca come “celerini assassini“ (ma fuori non è successo nulla!), “jimi, Eric, Mao Tse Tung” (il compromesso politico-musicale avanza!) e altri meno celebri ma più geograficamente collocati come un mastodontico “Forza Roma!” e un più generico “ladri, ladri”, che in Italia funziona bene sempre.
Anche oggi.
Dentro il Palaeur sembra di stare al Super Dome di New Orleans dopo l’uragano Katrina.
Lo sbraco più totale imperversa.
L’aria condizionata non esiste (c’era scritto sul biglietto che al Palaeur c’era, era un segno distintivo dell’epoca!).
Non importa però.
Il fascino è così forte che l’odore del profumo patchouli, misto a pecorino da calzini sporchi una settimana assomiglia, in quel momento per me, all’odore di una rosa di prima mattina: Straordinario!.
E se è il rock & roll, mi dico, deve essere così: let it be, lascia che sia
(le mie conoscenze dell’inglese erano, al momento del concerto, limitate a poche canzoni, poi sarei migliorato!).
Torniamo al disco più recente del gruppo che la formazione inglese questa sera presenterà e che da poco ho comprato e di cui vado fiero: esso ritrae una serie di poliziotti motociclisti che si sono montati in testa l’uno all’altro e io ho passato l’intera settimana precedente al concerto a studiare la loro faccia per tentare di capire come avevano fatto a non cascare tutti.
Ma certo!: era stata la musica a dargli la forza di resistere, mi ero detto e giustificato: un cazzotto nello stomaco che li aveva compressi e impacchettati l’un sopra l’altro.
Ero, infatti, sicuro che la foto di “Rock On”, questo il titolo dell’album, era stata scattata mentre i motociclisti stavano ascoltando il contenuto sonoro del disco, una musica tozza e sporca e dura dal sapore blues che riempiva il cuore di piacere.
All’epoca del disco ero certo, anzi certissimo che le foto di copertina si scattavano facendo ascoltare ai soggetti i dischi che avrebbero rappresentato, per una semplice questione di pertinenza ed aderenza ai contenuti, no?
Ad esempio alla mucca di Atom Heart Mother avevano – sicuramente- fatto sentire tutta la suite dei Pink Floyd e alla tipa sul disco di debutto dei Black Sabbath tutto l’album dei quattro di Birmingham.
Andatevi a riguardare la copertina in formato ellepi dell’epoca e ditemi se sbaglio oppure no!
Riflessione a parte, devo confessare che avevo, in cuor mio, una vaga speranza di ritrovare sul palco del Palaeur, oramai un brodino per la temperatura tropicale, quello stesso show circense visto sulla cover del disco degli Humble Pie ma quando i quattro musicisti montano sul palco dell’enorme caverna capisco che le cose, per la prossima ora, sarebbero andate diversamente.
Annunciati fra una selva di fischi diretti a David Zard, un giovane impresario ebreo che si vocifera ricicli i soldi e lavori per la CIA, i Pie entrano come leoni nell’arena.
Il leader del gruppo, “un sola”, è in verità uno spiritato tappetto non più alto di Renato Rascel (all’epoca i termini di paragone erano quelli, mi dispiace. Prince non c’era ancora e se c’era aveva la mia età, 13 anni!) che sbraita e urla e si rotola sul palco mentre i suoi soci con una certa nonchalanche gli ruotano intorno in una danza cannibalesca.
Il gruppo, attaccatosi agli ampli con lunghi cavi come funi, con lo spirito del musicista plug & play al quale frega ‘n cazzo tanto sa sempre cosa tirar fuori dal suo strumento –infatti fischia tutto!- partono con un boogie orgiastico menando come pazzi e sparando bordate dai loro amplificatori Marshall ed Orange alle prime file, centrandomi, immancabilmente, in pieno.
E’ in quel momento che comprendo che gli Humble Pie suonano con l’intenzione di fare male all’ascoltatore e lasciare il segno.
Questo rock, mi dico, è, a parte il dolore auricolare, un piacere, un vero piacere: una venatura di blues e rhythm & blues emana da tutti i pori dei quattro.
I riff sembrano sciabolate!
Il bassista(Gregg Ridley), un biondo crinito, sventola i lunghi capelli a tempo con maggiore insistenza proprio quando il batterista(Jerry Shilrey) cerca disperatamente di bucare i tamburi con delle mazzate così roboanti che il Palaeur trema e pare stia per cadere.
Un secondo chitarrista con la faccia d’angelo (Peter Frampton) tiene le redini della danza ed è così giovane che per mesi e anni a venire sono rimasto convinto fosse minorenne.
Nel mezzo della baraonda Steve Marriott canta il blues come non avevo visto fare a nessun bianco.
A un certo punto mi soffermo sugli abiti di scena del tappetto: pantaloni di flanella (cazzo! è giugno) tenuti su da delle bretelle con la union jack e delle scarpe basse di corda. Niente altro.
Marriott è matido di sudore. Sono talmente vicino a lui che noto un’otturazione tra i molari destri superiori. Ogni tanto, per allentare la tensione sputa per tera e si grata il sedere.
Lo show va avanti con la furia di quello che sa che il traguardo è in cima alla montagna.
Non so dietro di me il gradimento, ma qui davanti, nel golfo mistico, il feeling è altissimo.
Gli Humble Pie chiudono l’ultimo pezzo con la stessa classe con cui un camionista sonnanbulo lanciato a tutta velocità tira il freno a mano a un metro da un muro.
Adesso Steve Marriott è steso al suolo come un pugile a knock out.
La gente applaude ma lui resta lì. Immobile. Nell’enfasi e nell’estasi generale la gente continua ad applaudire. Poi il silenzio scende per un attimo sul Palaeur ma dal brusio è evidente che il pubblico non ha capito la gravità della situazione.
Tutti riprendono a battere le mani mentre io inizio ad andare in paranoia e penso che Steve Marriott sia morto qui, stasera, A Roma, davanti a miei occhi, a un metro da me.
E’ tutta una ridda di pensieri velocissimi. Eppure dopo l’iniziale spavento il mio umore cambia repentinamente e mi esalto e mi galvanizzo all’idea di aver visto il primo morto da troppo rock. Cazzo che scoop!!! E a soli tredici anni…
Due tecnici appaiono a questo punto sul palco e, senza proferire parola né una smorfia sul viso, prendono Marriott di peso e se lo tirano via sulle spalle.
Poi, è questione di un attimo, il gran colpo di teatro: le luci si accendono tutte e Steve ritorna in scena, sorridente, seguito dai suoi e saluta, tutti salutano. Gli applausi si moltiplicano.
Per le migliaia di persone non è accaduto nulla. L’ultimo è un applauso da Colosseo alla “morituri te salutant” quello che accompagna la scena finale, mentre dagli spalti ricompare l’immancabile coro “Forza Roma, Forza Lupi, Sò finiti i tempi cupi”.
Steve- penso- sei “un sòla”…
Questo è il mio ricordo degli Humble Pie come supporter dei Grand Funk Railroad, trio di cui rimembro ben poco se non che facevano il doppio del casino dei Pie.
Il repertorio di Marriott e soci?, chiederanno i (pochi) fans rimasti oggi aficionados della band: esattamente il doppio live “Rockin’the Fillmore” registrato solo il mese prima, che andai ad acquistare sempre a Viareggio, sempre da Fontana, appena pubblicato, e immediatamente mandato a memoria da allora fino a oggi.
Quando tutto il pubblico defluisce lentamente dal palasport noto qualche faccia famosa fiorentina mentre cerco di raccogliere i commenti. Fra loro spicca per altezza e sagacia “La Nonna” personaggio che anima i pomeriggi del “Sala Disco” di via Vecchietti, a Firenze, l’unico negozio che venda dischi d’importazione, con i suoi commenti. È uno, “La Nonna” a cui piacciono solo i dischi” strani” ma i concerti, quelli no!, non se ne perde uno e già nel 1971 è un veterano.
“La Nonna” a voce alta, come presto scoprirò essere sua abitudine fare, licenzia la serata, senza essere stato interpellato da alcun presente, con due sole parole: ”Bella Cagata” ma non farà in tempo a terminare l’ultima sillaba che lo stesso barbuto castigatore di cui sopra, facendosi larga tra la gente, lo mette a terra con “una pizza” tirata con una copia accartocciate del quotidiano “Il Messaggero” ( dove molti anni dopo il presunto o il suo sosia, sarebbe andato a lavorare), potente almeno due volte quella del pomeriggio e, fra le risate e i lazzi, lo liquida nello stesso modo con cui aveva liquidato nel pomeriggio il suo concittadino: ”tu nun ce capisci un cazzo de stà robba!” aggiungendo perentorio”...e tornatene a casa” concludendo con l’immancabile firma capitolina: “stronzo!”.
La serata finisce lì.
Enuff said!
Le parole del barbuto sceriffo, miste ai watt della serata e al ricordo della mezza bottiglia di Jack Daniel che Marriott si era tirato giù nel corso dello show, mi faranno girare la testa per un bel po’, conscio di aver toccato con mano il vero rock, in tutte le sue forme e sfumature, orgoglioso di essermi conquistato la prima fila, di aver vissuto una “vera” rissa per motivi musicali, di quelle che ti fanno togliere il saluto, nel nome di un ideale.
Resto solo deluso (un po’, solo un po’…) dal mancato decesso in diretta, lì, sul palco, di Steve Marriott.
I Pie mi resteranno per sempre nel cuore.
Prima della sua prematura scomparsa, il 20 aprile 1991 nel suo cottage nell’Essex, avrei rivisto Steve Marriott ancora una volta, quasta volta insieme a Ronnie Lane, già suo compagno d’avventura nei mod-issimi Small Faces, nel 1980, dal vivo all’Hope & Anchor, uno storico rock club di Londra, ma l’intera serata aveva un tono dimesso, da viale del tramonto, da dimenticare.
Meglio mantenere forte nella memoria il ricordo degli Humble Pie.
Quei tipi Plug & Play dallo spirito olimpionico che non si arresero neanche davanti all’evidenza dei tempi che cambiavano più veloci dei loro boogie.
Ricordate, allora: colui che cerca di mutuare la vecchia storia per cui chi ha vissuto i sessanta se ve li racconta significa non c’era e tenta di rifilarvi la stessa abbinandola ai settanta, è solo “un sòla”.
Per zittirlo, tirategli “una pizza”…
Ernesto de Pascale
Discografia Humble Pie
‘As Safe As Yesterday’
Immediate – 1969
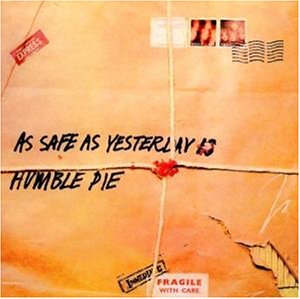
L’esordio della band è il primo tentativo di Steve Marriott di coniugare le sue pulsioni R&B e blues con l’attitudine rock che già stava dando fortuna ai “fratelli” Free, cercando però di ottenere un suono più marcatamente americano. La formula non è ancora ben rodata, ma canzoni come ‘Desperation’, la title track e l’acustica blues ‘Alabama ‘69’ colpiscono nel segno ben supportati dalle più immediate ‘Bang!’ e ‘I’ll Go Alone’. Menzione a parte per ‘Growing Closer’, un breve divertissement blues, cajun e folk, che sembra richiamare anche il suono dei Jethro Tull, i quali proprio nel 1968 avevano pubblicato il loro disco d’esordio ‘This Was’. Nel disco non viene inclusa quella ‘Natural Born Boogie’, che diviene il loro primo hit single (top 4 della classifica inglese).
‘Town & Country’
Immediate – 1969

A pochi mesi di distanza dall’esordio e forte del successo del loro singolo, la band pubblica un nuovo album che già dalla copertina pare discostarsi dal precedente: Ridley e Frampton campeggiano seduti in una stanza di una casa di campagna inglese, mentre Shirley e Marriott (con una smorfia in viso che lo fa sembrare quasi un folletto) sono relegati nel retro copertina immortalati nei pressi di un ruscello; tutto lascia intendere ad una svolta acustica che trova conferma nei solchi del vinile che è dominato dai toni soffusi, tanto che solo due canzoni delle 11 sono riff based. ’The light Of Love’, con la sua intro di sitar, pare voler strizzare l’occhio al pop ed alla classifica, mentre la cover di Buddy Holly ‘Heartbeat’ sembra più un omaggio agli Herd di Frampton ed agli Small Faces di Marriott. In questo album a corrente alternata trova spazio anche un blues (‘Silver Tongue’) e un momento di pura follia hippie come ‘Ollie Ollie’, ma tutto appare sfocato, ed anche le belle ‘Cold Lady’ e ‘Only You Can See Me’ paiono soffrire di questo forzato ammorbidimento sonoro.
‘Humble Pie’
A&M – 1970
Dopo il mezzo passo falso commerciale di ‘Town And Country’ ed il fallimento della Immediate, Marriott e soci vengono presi in scuderia dalla A&M e pubblicano l’omonimo terzo disco, che segna quasi un nuovo inizio, evidenziato anche dall’opener ‘Live With Me’, lungo brano cadenzato come lo era stato ‘Desperation’, dominato dall’organo Hammond. Il suono si fa sempre più rock con le sole ’Only A Roach’ e ‘Theme From Skint’ dal sapore country. Per due canzoni poi - l’intensa ‘Earth & Water Song’ e ‘Sucking On The Sweet Vine’ - la band tenta la strada della ballata, nella quale reminescenze folk si alternano ad improvvise impennate elettriche. La cover di un classico del repertorio di Willie Dixon - ‘I’m Ready’ - diventa un anthem degli Humble Pie che in questo brano si avvicinano al sound americano delle big southern band, pur mantenendo quel tocco ruvido, quel “rough edge” tipico del sound inglese.
‘Rock On’
A&M – 1970
Il titolo dell’album è una dichiarazione programmatica e ‘Shine On’ è il primo capitolo: rock potente pensato per le highway americane, a cui fa seguito ‘Sour Train’ dal ritmo negroide e sincopato; la band ha trovato finalmente il suo sound, smussando certi angoli e prediligendo una maggiore immediatezza che farà storcere il naso ai critici, ma che darà loro maggiori soddisfazioni commerciali e di pubblico. La versione di ‘Stone Cold Fever’ è solo un piccolo assaggio di ciò che questo brano diverrà dal vivo e la cover di ‘Rollin’ Stone’ di Chester Burnett prosegue quanto di buono la band aveva fatto con ‘I’m Ready’ di Willie Dixon. Anche i momenti acustici sono finalmente ben calibrati: dalla dolcezza di ‘A Song For Jenny’ con tanto di coro gospel e pedal steel guitar, al boogie scanzonato di ‘79th And Sunset’, passando per lo swing di ‘Red Neck Jump’ con Marriott che si diverte ad imitare Elvis.
‘Performance Rockin’ The Fillmore’
A&M – 1971
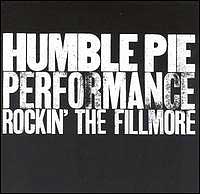
La celebrazione per ogni rock band avviene con la pubblicazione dell’album live. Gli Humble Pie non si smentiscono e per l’intera durata di questo doppio vinile celebrano la loro attitudine alla fusione dei generi. Dei 7 brani inclusi, solo uno - ‘Stone Cold Fever’ - porta la firma dei 4, mentre per il resto la band prende in prestito brani famosi della storia del blues e del R&B e li fa propri, stravolgendoli ed enfatizzandoli: i 24 minuti di ‘I Walk On Guilded Splinters’ sono come un temporale estivo o come una mareggiata invernale, tanto è il loro carico di feeling… La band non sembra paga, e scomoda Ray Charles con Marriott che canta ‘Hallelujah (I Love Her So)’ mostrando tutto il suo rispetto per “The Genius” e, al tempo stesso, la sua sfrontatezza quasi punk nel voler far sua la canzone. Ed il rito trova la sua apoteosi nella versione hard rock di ‘I Don’t Need No Doctor’ che da questo momento diviene una canzone degli Humble Pie a tutti gli effetti.
Smokin’
A&M – 1972

Con l’uscita di Peter Frampton che freme per avere più spazio e l’inserimento David “Clem” Clempson ex Bakerloo e Colosseum, la band è saldamente nelle mani e nelle corde vocali di Marriott che sterza per il suo R&B hard bluesy rock: ‘Hot & Nasty’, ‘The Fixer’, ‘Sweet Peace And Time’ ed il singolo ’30 Days In The Hole’ sono i testimoni perfetti della maturità della band. ‘You’re So Good To Me’ è una soul ballad con Marriott e Greg Ridley che si dividono le parti di voce, ben supportati da un coro femminile. ‘C’mon Everybody’ diventa un roccioso boogie che tanto influenzerà band come gli AC/DC ed i conterranei UFO. Marriott ha il suo momento di gloria nel lungo blues ‘I Wonder’: la sua voce graffiante si tinge di nero e si contorce come i campi di cotone al vento.
‘Eat it’
A&M – 1973

Con questo doppio album gli Humble credevano di raggiungere l’apice del loro successo e la consacrazione della loro esplosivo mix di R&B e hard rock ed invece… l’album non irrompe impetuoso nelle classifiche, complice un lotto di canzoni non sempre all’altezza del gruppo ed una registrazione farraginosa (con brani in studio e altri registrati dal vivo) che frena l’aggressività e la sfrontatezza del sound della band. Bisogna aspettare la versione live di ‘Black Coffee’ per ritrovare il gruppo che i fans vogliono. Marriott si sforza di dare pathos e feeling ad ogni sua interpretazione, ma spesso il sound appare pesante e stanco (‘I Believe To My Soul’ , ‘That’s How Strong My Love Is’). Alla fine la canzone migliore è l’acustica ‘Say No More’ che rimanda agli esordi della band.
‘Thunderbox’
A&M – 1974

Il processo involutivo della band continua inesorabile anche con ‘Thunderbox’ che ha dalla sua una produzione migliore del precedente album che, quanto meno, ci restituisce suoni più ruvidi e funky. Il disco però manca di sostanza e peso specifico: le canzoni sono sempre più dure e cattive, ma senza alcun nerbo. Ecco quindi spiegato perché sono le cover version di ‘I Can’t Stand The Rain’ e ‘Drift Away’ – cantata da Greg Ridley – a risultare le migliori canzoni di un disco che ha ben poco da offrire.
‘Street Rats’
A&M – 1975

‘Street Rats’ è uno strano album in cui l’apporto di un produttore di lustro come Andrew Oldham ha sicuramente frenato la verve della band senza però aver aggiunto niente di relativamente nuovo e, ancor più importante, significativo. La versione di ‘R’n’R Music’ è, per esempio, quanto di più stanco e privo di quella grezza potenza, di quel famoso “rough edge” che era l’elemento qualificante dell’intera band. Marriott si conferma gran crooner in ‘We Can Work It Out’ ma la sua voce è lasciata sola a dare colore e sostanza al brano, mentre il resto della band latita. Unica piccola gemma è la cover di ‘Rain’ sempre dei Beatles: il marchio Humble Pie torna finalmente a splendere con i cinque musicisti tutti intenti a suonare al meglio, ma è davvero troppo poco e la band si scioglie poco dopo l’uscita del disco.
‘On To Victory’
Atco – 1980
E’ l’album della reunion, con i soli Marriott e Shirley della formazione originaria ben coadiuvati da Bob Tench del Jeff Beck Group e Anthony “Sooty” Jones al basso. Il disco è bello energico e ha dalla sua alcuni brani - ‘Fool For A pretty Face’ , ‘You Soppy Pratt’ e ‘Further Down The Road’ - che rimandano ai bei tempi di ‘Smokin’ e ‘Rock On’. Purtroppo è anche evidente che la band è più impegnata a voler far rivivere il passato (vedi la cover ‘Baby Don’t You Do It’, che vorrebbe essere graffiante senza riuscirci) che a dare dignità al presente. Peccato perché Steve Marriott, malgrado i problemi di salute, continua ad avere una voce tra le più ricche di feeling, e la cover di ‘My Lover’s Prayer’ di Otis Redding è magistrale.
‘Go For The Throat’
Atco – 1981
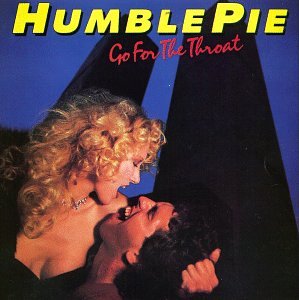
Delusi per il poco riscontro di vendite del precedente album, il quartetto dà alle stampe un album di cui loro stessi sembrano essere poco convinti e riesce a far ancora peggio di ‘On To Victory’ sancendo la fine della band. A poco valgono la versione sterilmente dura di ‘All Shook Up’ o la ripresa di ‘Tin Soldier’ degli Small Faces che è suonata diligentemente e senza cuore proprio da colui che contribuì a scriverla.
‘Back On Track’
Sanctuary – 2002

Un po’ a sorpresa il nome Humble Pie viene resuscitato da Jerry Shirley e Greg Ridley che si fanno aiutare da Bobby Tench e dal chitarrista David Colwell, principale responsabile della rinascita dei Bad Company e principale autore dei 10 brani inclusi in questo CD. Il cerchio si chiude: se è innegabile che i Bad Company abbiano avuto negli Humble Pie un chiaro riferimento stilistico musicale che ha permesso loro di superarli in successo e vendite, ecco che adesso gli Humble Pie proprio ai Bad Company si rifanno proprio per riprendersi quello che a loro spetta. Il disco è piacevole, come lo era d’altro canto ‘On To Victory’, anche se la mancanza di Marriott si sente. Anche qui prevale il sapore agrodolce del bel tempo che fu, sensazione che si fa schiacciante se si pensa che poco dopo la sua pubblicazione, Greg Ridley morirà di attacco cardiaco. Una curiosità: la band ringrazia David Gilmour per aver reso possibile la realizzazione di questo disco.
Raccolte e live postumi
A nome Humble Pie sono uscite un numero davvero imponente di raccolte postume più o meno autorizzate, tra queste ci sentiamo di segnalare le seguenti:
‘Hot’n’Nasty: The Anthology’, A&M – 1994 2cd
‘Natural Born Boogie – The Immediate Years’, Sanctuary – 2004 2cd

A queste si aggiungono un’altrettanto nutrita serie di live, tra i quali meritano una menzione:
‘King Biscuit Flower Hour Presents: In Concert Humble Pie’ – King Biscuit – 1996
‘Live At Whiskey A-Go-Go 1969’ – Sanctuary – 2002
Jacopo Meille