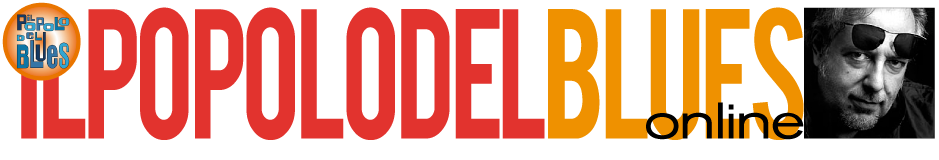The state I'm in
Le due vite del signor Greenbaum
Le due vite del signor Greenbaum
(Peter Green, 1946-2020 in memoriam)
Formidabili quegl’anni, direbbe qualcuno. Ascoltando Hard Road, ti chiedevi dove diavolo John Mayall – le cui doti di talent scout non erano ancora emerse chiaramente – avesse trovato questo Peter Green. Green divento’ istantaneamente leggendario come il chitarrista che aveva spodestato reuccio Clapton dal trono del British Blues, una storia molto britannica infantilmente riportata dai media di allora. Vale sempre la pena di ricordare che si era ancora nella preistoria delle comunicazioni, che il Blues lo trovavi a malapena in qualche trafiletto e che quelli tra noi più facoltosi e dotati per le lingue compravano rare copie di giornali musicali in edicole di centro città.. Comunque apparve chiaro che la chitarra, strumento centrale nel Blues forse quanto l’armonica e la voce, e chi la suonava era destinato a notorietà sicura. Negli Stati Uniti vivevano indisturbati i maestri, appunto i tre re, BB King, Albert King, e Freddie King – dei tre il piu’ influente tecnicamente, seguiti da uno sciame di chitarristi che si sarebbero rivelati straordinari, da Buddy Guy, Otis Rush e via andando. Il British Blues riproponeva, con qualche stile locale e molto Jazz, il Blues Americano, quello vero con la B maiuscola creando un ponte tra Stati Uniti e Europa, trasformando il Blues da fenomeno etnico a musica popolare. Peter Green’s Fleetwood Mac – fondamentale la Blues Jam at Chess – erano una delle colonne di questo ponte immaginario. Migliaia di giovani, chitarristi o meno, ebbero accesso al Blues attraverso la magica chitarra di Green, definito semplicemente come “quello meglio di Clapton” ossia come dire il migliore chitarrista Blues al di qua dell’Atlantico. Tanta roba. Anche perché i chitarristi inglesi bravini abbondavano: Jeff Beck, Jimmy Page, Kim Simmonds solo per citarne alcuni. Il British Blues era un movimento musicale importante, pieno di artisti talentuosi e versatili e Green ne era una figura centrale. Secondo l’usanza dell’epoca, fine anni sessanta, molti musicisti intrapresero una svolta psichedelica che per alcuni di loro si rivelo’, col senno di poi, letale. Anche qui Green fu in prima linea, il suo “The end of the Game”, dal titolo profetico, resto’ e resta musicalmente incomprensibile ai più. La prima vita del Signor Greenbaum fini’ li’, si parlo’ come d’abitudine, di un abuso di droghe, di alcolismo, di uno stato mentale comunque incompatibile con una vita normale, forse tutto vero, ma che importanza potevano avere le cause sulle conseguenze? Passarono diversi anni prima di rivedere il Signor Greenbaum che pur riabbracciando la chitarra sembrava un uomo diverso ma soprattutto un musicista diverso, come se avesse passato tutti quegl’anni, musicalmente parlando, in varechina. Con quella finezza che li contraddistingue, molti giornalisti continuarono imperterriti a chiedergli degl’abusi, della schizofrenia e di come il British Blues avesse dovuto fare a meno di uno dei suoi migliori chitarristi. Green rispondeva gentilmente, con l’aria un po’ assente, tentando di proporre la sua musica al tempo presente, tutto sommato con poca fortuna. Musica che non era malaccio, negli standards di un Blues accettabile senza grandi picchi, a tratti piuttosto liquido. Seguendo una prassi abbastanza nota, incise una raccolta di pezzi di Robert Johnson sulla quale quasi tutti i recensori furono unanimi nel dire che si sentiva il tocco di un grande chitarrista. I soliti esagitati titolarono che Peter Green era “tornato”. Non era vero. Anzi piano piano torno’ nell’ombra – nonostante continuasse a incidere – e di lui rimane questa immagine di uomo anziano, un po’ grassottello, dall’aria fricchettona. L’ascolto dei dischi, alcuni di buona fattura, piu’ recenti genera un senso di malinconia. Difficile credere che molti anni prima quello fosse stato il riccioluto chitarrista di Black Magic Woman e di Albatross, quello che detronizzò Slowhand.
Luca Lupoli
Tagged blues, British Blues, Fleetwood Mac, Peter Green